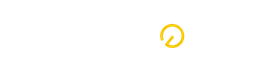Mi chiamo Artemisia Gentileschi e sono nata in una calda giornata di luglio del 1593, in una Roma lercia e chiassosa, mentre al soglio pontificio sedeva Clemente VIII. Ero appena venuta fuori dal ventre caldo di mia madre Prudenzia, quando intuì che non l’avrei vista per molto altro tempo ancora: pochi anni dopo morì. Mio padre Orazio Gentileschi era pittore ed era toscano, anzi pisano. Il suo vero cognome era Lomi, ma per distinguersi dal fratellastro Arturo, anch’egli pittore, si firmava Gentileschi. Anche io fui pittrice, non per eredità, ma per talento. Non ero ancora alta un metro e mezzo quando imparai ad impastare i colori e ad associarli senza che io compissi alcuno sforzo. Il signor Roberto Longhi, successivamente, disse di me che ero l’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa fossero la pittura, il colore o l’impasto. Troppo generoso, forse, il signor Longhi se prima di me il mondo della pittura è stato grato ad alcune mie colleghe che ebbero un discreto successo: Sofonisba Anguissola, Fede Galizia, Lucrina Fetti. Tutte bravissime donne e artiste, ma che, forse, non ebbero la mia stessa fortuna.
Gentileschi padre mi insegnò a disegnare
Mio padre capì subito che ero predisposta all’arte del pennello, tanto da insegnarmi la rigorosa tecnica del disegno. Ancora giovinetta, ho potuto conoscere le opere di grandi maestri che a Roma in quegli anni lavoravano all’interno degli edifici pubblici e privati. Committenti che volevano fare ancora più grande e maestosa la città del papa. Così potei ammirare le drammatiche opere di Caravaggio che tra San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo lavorava, i virtuosismi dei Carracci alla Galleria Farnese, la delicatezza del Domenichino e la classicità raffaellesca di Guido Reni. Più guardavo queste opere e più mi rendevo conto di quello che avrei voluto fare da grande. Come dicevo, mio padre mi insegnò a disegnare, ma ero debole nella prospettiva, così mi introdusse alla tecnica il suo amico Agostino Tassi, che era molto amico del babbo a quel tempo, perché lavoravano gomito a gomito agli affreschi del Casino delle Muse di Palazzo Pallavicini-Rospigliosi.
È colpa mia se la natura mi fece così procace?
A casa mia non si era mai tranquilli, era sempre un andirivieni di pittori, amici del babbo, e tra questi c’era anche Agostino, che non lesinava la sua presenza. Io a quel tempo ero giovane, con le forme di una donna bella e fatta. Ma ditemi, è colpa mia se la natura mi fece così procace? In casa ero in compagnia della mia amica Tuzia, che papà qualche anno prima aveva fatto trasferire, insieme alla sua famiglia, al secondo piano di casa nostra. Voleva che fossi in compagnia di un’altra donna, sia in casa che fuori, perché le donne sole mica potevano stare. Eh no, a noi donne era sempre necessaria la sorveglianza, sempre guardate a vista, nel caso in cui ci macchiassimo di un qualche peccato mortale o ci facessero del male. Ma tanto era uguale, con o senza la sorveglianza o la compagnia, come volevasi chiamarla. Io stessa nel maggio del 1611 venni violentata dall’amico del babbo. Fu terribile, ebbi paura quando chiuse la camera a chiave e dopo averla chiusa mi gettò sul letto bloccandomi il petto con la mano e mi mise un ginocchio in mezzo alle cosce affinché io non potessi chiuderle. Cercavo con tutte le mie forze di impedirgli di compiere l’atto, ma mi serrò la bocca con un fazzoletto onde evitare che io urlassi, così mi violentò.
Il mio unico peccato: essere donna e pittrice

Ormai ero violata e la società romana era già pronta a condannarmi a vita nonostante fossi stata io la vittima. Implorai Agostino di sposarmi. Lui mi fece credere che lo avrebbe fatto, ma scoprì che era già impalmato. A quel punto convinsi babbo a denunciare il suo amico se non avesse voluto avere una figlia marchiata a fuoco a vita. Ecco perché il processo per stupro iniziò solo quasi un anno dopo, nel marzo del 1612, perché per lunghi mesi avevo creduto alle parole del mio aguzzino, per il quale, forse, mi stavo innamorando. Durante il processo dovetti ascoltare ogni tipo di accusa da parte del Tassi e dei suoi testimoni corrotti e subire le peggiori ingiurie da parte del comune uomo di strada, perché il mio unico peccato era di essere stata donna e pittrice. Rimasi fedele alla mia testimonianza e anche sotto tortura, quando mi legarono le dita con le corde e le strinsero fino a farle sanguinare, ammisi la violenza perpetratami. Il processo finì il 27 novembre del 1612 con la condanna del Tassi a cinque anni di lavori forzati o l’esilio. Lui scelse l’esilio.
Dipinsi la rabbia di Artemisia Gentileschi
Pochi giorni dopo sposai Pierantonio Stiattesi – un uomo che non amai mai o forse amai a modo mio -, era il 29 novembre 1612. Ebbi quattro figli, ma solo una fu talmente forte da resistere agli antichi mali: Prudenzia. Esiliato fu il mio aguzzino, ma esiliata lo fui anche io: vittima ed esiliata. Volevo essere donna e pittrice, ma Roma non era pronta per una come me. Agostino mi violentò carnalmente e Roma verbalmente. Fui costretta a lasciarla per trovare pace e fortuna altrove, ma prima di abbandonarla dipinsi la mia rabbia in una feroce Giuditta che decapitava Oloferne. L’ancella bloccava il corpo morituro del re babilonese, così come il Tassi bloccava il mio mentre compiva la sua violenza. La mia ira si tinse di rosso come il sangue che, sgorgando dalla testa del sovrano morto, inzuppava i bianchi lini del letto. Giuditta compiva l’atto della decapitazione con una tagliente spada imprimendo ad essa la stessa forza che le avrebbe impresso un uomo nel compiere il gesto. Il volto di Giuditta non esprimeva alcun sentimento, se non il disgusto per l’uomo che aveva sotto di lei.
Dare voce alle donne nell’arte, se in vita non era possibile

Da ora in poi volli dare voce alle donne, almeno nell’arte, se in vita non era possibile. Nei miei quadri dipinsi solo figure femminili: belle, eleganti e procaci. Perché avrei dovuto castrare la
loro bellezza? Anche quando ammazzavano un uomo dovevano esprimere la loro grazia e civetteria. Così come quando dipinsi nel 1620 una bellissima e terribile Giaele che, con la sua serica veste gialla, conficcava nel cranio di un Sisara dormiente un enorme chiodo tramite un martello. Alle spalle della composizione lo sfondo nero lo interruppi, all’improvviso, con il plinto di una colonna su cui apposi la mia firma. Inconsciamente forse volli rammentare, a chi avesse visto il dipinto, che quella procace Giale fossi io.
Dipinsi sempre, da Roma a Firenze, da Venezia a Napoli
Lasciata Roma vagai per varie corti d’Italia e in tutte venni incoronata artista. A Firenze soggiornai
dal 1614 al 1620. Furono anni eccitanti quelli. Venni accolta nell’Accademia delle Arti del Disegno; conobbi Cristofano Allori; ebbi i favori del Granduca Cosimo II de’ Medici e della granduchessa-madre Cristina; ebbi contatti epistolari con Galileo Galilei; fui ammirata come artista da Michelangelo Buonarroti il giovane, nipote del grande scultore. Dipinsi, sempre. Ogni anno che restai a Firenze composi opere richiestemi dai committenti. Nel 1620 tornai a Roma credendo di poter ricominciare nella città che mi diede i natali, ora che ero diventata pittrice affermata, ma ancora una volta compresi che l’onta subita mi rimaneva appiccicata come cartapesta e orfana di committenti lasciai la città papale per Venezia, dove fui accolta come si deve a una “pittora” come me. Nel 1630 decisi di trasferirmi a Napoli. All’epoca la città del Regno era in pieno fermento artistico. Nuovi palazzi, nuove chiese e quindi proficue commissioni. In un ambiente artistico chiuso quale era quello napoletano seppi farmi accettare come donna e come artista. Ebbi la protezione del viceré Duca d’Alcalá e strinsi un’intensa collaborazione artistica con Massimo Stanzione. La committenza religiosa napoletana, per la prima volta nella mia vita, mi commissionò un’opera per una chiesa: tre tele per la cattedrale di Pozzuoli. Fu una commissione importante per me: è come se fossi stata riabilitata davanti a Dio. Qui dipinsi un San Gennaro nell’anfiteatro di Pozzuoli, un’Adorazione dei Magi, i Santi Procolo e Nicea. In queste opere abbandonai la drammaticità che aveva caratterizzato le precedenti opere e abbracciai una maggiore compostezza utilizzando pigmenti bruni, che tanto bene si confacevano a soggetti di questo tipo, rendendo l’atmosfera più intima e rarefatta.
Fianco a fianco con Gentileschi padre, questa volta però da protagonista
Nel 1638 mi chiamò a Londra a corte Carlo I. Lì c’era mio padre, che da qualche tempo era diventato pittore di corte. Avrei voluto volentieri non andarci, pur di non vederlo. Il farabutto poco dopo la condanna del Tassi riallacciò l’amicizia e ciò fu per me imperdonabile, una lama nel cuore. Ma non si poteva negare l’invito di un regnante come Carlo, così mi armai di pazienza e lavorai fianco a fianco con mio padre, questa volta però da protagonista. Lui morì improvvisamente l’anno dopo. Io rimasi, invece, a corte per alcuni anni, fino al 1642, quando ritornai a Napoli. Continuai a dipingere ancora e ancora fino a quando nostra signora morte mi accolse a sé nel 1653.
Mi chiamo Artemisia Gentileschi e sono nata nel 1653. Fui violentata, ma fui artista e donna.
Se avrete voglia, sarò felice di accogliervi fino al 7 maggio nelle stanze di Palazzo Braschi a Roma in una mostra intitolata Artemisia Gentileschi e il suo tempo.
Scusate Donna Gentileschi se vi togliamo la scena, ma vorremmo presentarci.
Ci chiamiamo Fabiana, Rosaria, Rosamaria, Stefania, Giulia, Elizabeth… e siamo le centosedici donne ammazzate dai nostri mariti, fidanzati e compagni nel 2016. Tutte volevamo una sola cosa: essere, come lei, donne e libere. Ora, però, giacciamo due metri sotto terra.